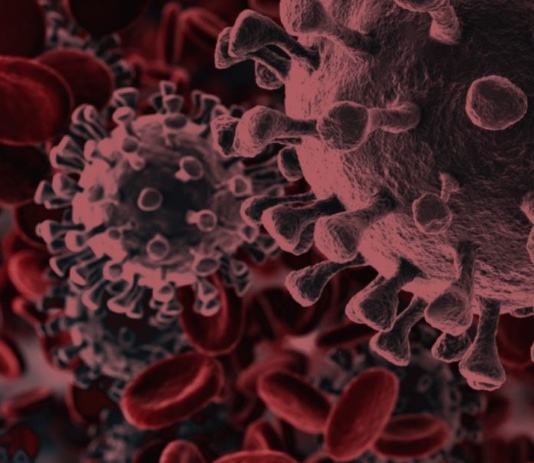a cura di Gianluca Vivacqua –
È vero: ancora non possiamo dire di essere fuori dall’emergenza pandemica. Molti parlano della lotta al coronavirus paragonandola a una guerra mondiale: probabilmente, se fosse come la seconda, saremmo già a un buono stato di avanzamento. Avremmo già visto (e lo abbiamo visto!) il Blitzkrieg del virus e poi l’arrivo degli alleati anglo-americani, AstraZeneca, Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson. Contemporaneamente, ecco i russi con Sputnik. Forse (sottolineiamo il forse) adesso ci troveremmo nelle fasi convulse che precedono la fine: in Italia, dove sembra sia scoppiata una piccola “guerra civile” tra no vax e partigiani del vaccino, e nel resto del mondo, alle prese con l’ultimo, violentissimo colpo di coda delle forze (virali) occupanti. Periodizzare, anche per analogia, un evento così traumatico significa sforzarsi di ricondurlo alla razionalità di una narrazione che cerca di controllarne il percorso. Condizione necessaria per riflettere più lucidamente sul suo inizio: quello che cerchiamo di fare col prof. Marco Gerdol, genetista dell’università di Trieste, attento studioso dell’evoluzione genomica del Covid.
– Professore, è ormai storicamente e scientificamente assodato che il coronavirus è stato esportato dalla Cina: ma per quanto riguarda l’Europa, la storia della diffusione del contagio resta particolarmente complessa. Lei è d’accordo con la tesi del focolaio iniziale di contagio nell’Europa centrale? E cosa pensa di chi parlava di “focolai autoctoni” nell’Italia settentrionale?
”L’iniziale diffusione in Europa con ogni probabilità è stata fortemente influenzata dal movimento di un numero tutto sommato relativamente piccolo di persone infette che hanno esportato il virus dalla provincia dell’Hubei all’estero. Dinamiche legate in parte anche al caso hanno poi fatto sì che i contagi continuassero a viaggiare sotto traccia per diverse settimane, scambiati probabilmente per infezioni respiratorie stagionali anche perché inizialmente legate a viaggiatori e dunque persone giovani che godevano di condizioni di salute relativamente buone. Queste dinamiche hanno fatto sì che la situazione pandemica esplodesse prima in Lombardia e poi in altre regioni europee e dell’America settentrionale, quasi sempre caratterizzate dall’essere centri nevralgici dei trasporti internazionali e zone alta densità abitativa, basti pensare ad esempio a quanto accaduto a New York. L’idea di focolai “autoctoni” nel nord Italia, ovvero slegati epidemiologicamente da quello originario di Wuhan e presenti nel nostro paese già da mesi (secondo alcuni già dall’autunno 2019) è del tutto priva di fondamento sia alla luce dei dati genomici a nostra disposizione, che ci permettono di tracciare grazie alle mutazioni che si accumulano nel genoma virale l’origine geografica dei cluster di contagio, sia alla luce dei dati sulla mortalità generale, che non si sono discostati dalla media degli anni precedenti fino a fine febbraio 2020” .
– Potrebbe essere sempre stata l’Europa la colpevole della diffusione del virus anche oltre-Atlantico?
”Indubbiamente la grave situazione pandemica che ha colpito la east coast americana è stata legata più all’importazione di casi dall’Europa che dalla Cina, sebbene i primi casi americani sulla west coast fossero collegati ad importazione diretta dall’Hubei. Questo, oltre ad essere dovuto ad un flusso di persone molto superiore tra Europa e Nord America di quanto non fosse stato nel medesimo periodo quello tra una Cina già in lockdown ed in Nord America, può anche essere ricondotto ad un semplice ma cruciale fattore, ovvero l’acquisizione da parte di SARS-CoV-2 di una mutazione a carico della proteina spike (D614G) che lo ha reso molto più trasmissibile. L’assenza di questa mutazione nel cluster di Wuhan ha probabilmente reso più semplice l’isolamento del focolaio che si era venuto a creare, mentre la sua presenza in Europa ha reso fin da subito ogni tentativo di contenimento molto difficoltoso. Va però detto che in parallelo a quanto accaduto in Europa il virus si stava diffondendo in modo del tutto indipendente anche in altre zone, anche se all’epoca non potevamo averne traccia a causa di un monitoraggio del tutto insufficiente: l’Ecuador, che ha vissuto nella provincia del Guayas una situazione paragonabile per gravità a quella lombarda ad aprile 2020, è un caso emblematico. In sostanza in una situazione di questo genere è davvero difficile individuare dei veri colpevoli: sono state le dinamiche stesse del mondo moderno, con le sue connessioni ed i viaggi internazionali a contribuire alla diffusione globale del virus ben prima che ci si potesse rendere conto della gravità della situazione” .
– In generale comunque sembra che l’epidemia (con alcune eccezioni importanti, come l’India) sia stata più devastante nel nord del mondo, più precisamente in corrispondenza dell’occidente ricco e benestante, che non nel sud, dove comunque non si attendeva certo l’avvento del coronavirus per vivere l’esperienza quotidiana di un flagello sanitario. Secondo lei questo perché?
”In realtà si tende spesso a guardare le metriche sbagliate per valutare l’impatto sanitario della pandemia in paesi che sono caratterizzati da una struttura demografica molto diversa. Il covid-19 è una malattia che, come abbiamo imparato, colpisce in modo preponderante la popolazione anziana, con tassi di letalità che sono superiori di ordini di grandezza superiori negli ultrasettantenni rispetto ai giovani. Quasi tutti i paesi dell’occidente ricco e benestante sono accomunati da una popolazione mediamente piuttosto anziana e fragile, con un’incidenza non trascurabile di fattori di rischio notevoli (quali ipertensione, diabete ed obesità) anche tra persone di mezza età. Sotto questo punto di vista è atteso che, a parità di diffusione del virus, il numero assoluto di decessi possa essere superiore in un paese occidentale rispetto a quello di un paese in via di sviluppo. L’impatto sanitario della pandemia può essere meglio valutato sulla base degli eccessi di mortalità rispetto alla media degli anni precedenti, che danno una buona idea di quanto il numero di decessi osservati abbia superato quello atteso. Questo approccio ha anche il vantaggio di permettere un sommario conteggio dei decessi covid mai conteggiati ufficialmente, cosa che purtroppo avviene molto comunemente in aree rurali di grandi paesi prive di ospedali ad esempio, oltre a quelli legati indirettamente alla pandemia, ovvero causati dal mancato accesso a cure e diagnosi, cosa che si è notata in modo particolare ad esempio in Sud Africa, dove gran parte della popolazione è sieropositiva o affetta da tubercolosi.
Questo approccio cambia completamente le prospettive: in Italia, così come nella maggior parte dei paesi occidentali, l’eccesso di mortalità su base annua si attesta tra il 20 ed il 25%, mentre i paesi in testa a questa triste classifica sono quelli dell’America latina. Perù con il 160%, Ecuador e Bolivia con l’85%, Messico con il 75%. Dal momento che ben pochi paesi dell’area africana ed asiatica sono dotati di registri elettronici dei decessi, non è possibile estendere queste considerazioni a paesi come ad esempio l’India, dove è plausibile che il numero reale di decessi per covid sia stato fino a dieci volte superiore. Esistono tuttavia delle notevoli eccezioni e non sono pochi i paesi che, pur non potendo vantare un sistema sanitario moderno e all’avanguardia, sono riuscite a limitare gli effetti della pandemia in modo invidiabile, facendo leva sulle misure di contenimento. Per questi paesi il vero problema rischia di arrivare in questa fase, dal momento che le possibilità di accesso ai vaccini sono tutt’altro che eque su scala globale”.