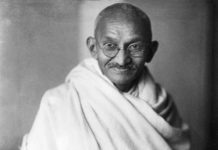di Leonardo Altomare –
Al centro delle politiche coloniali prima e di quelle neocoloniali all’indomani dell’indipendenza degli attori del continente, l’Africa riveste da sempre un ruolo principale nella complessa strategia geopolitica mondiale. Il cambiamento dei protagonisti sullo scacchiere africano, la presenza costante dei vecchi attori europei e sopratutto le modalità di esternazione delle interazioni dei soggetti coinvolti, consentono di identificare nella c.d. “culla dell’umanità” un pattern nel quale convergono da un lato residui di politica di potenza aggressiva delle nazioni più forti volte a mantenere condizioni di sudditanza, forme di dominio diretto ed indiretto dell’economia ed ingerenza politica e dall’altro interazioni di potere ancorate a logiche di soft power.
Soggetto protagonista nell’esercizio di tali logiche è senza dubbio la Cina. La ricchezza in termini di risorse naturali, così come il potenziale commerciale del mercato africano, rappresentano per Pechino un vero e proprio affare, basti considerare che negli ultimi 15 anni, secondo quanto riportato dal China Africa Research Initiative, i flussi annuali dei c.d. FDI (Foreign Direct Investment – Investimenti Diretti Esteri) hanno registrato un incremento costante e significativo, passando da 75 milioni di dollari nel 2003 ai 5,4 miliardi nel 2018. Nel quadro di una strategia di “potere morbido”, volendo riprendere e riproporre il termine coniato dal politologo statunitense Joseph Nye, l’interesse commerciale ed economico cinese in Africa procede di pari passo con logiche di natura geostrategica, tanto che l’approccio al continente è da considerarsi tattico nell’ottica di confronto sullo scacchiere internazionale con gli Stati Uniti e lungimirante in relazione alle future dinamiche globali che continueranno a vedere indiscutibilmente centrale il ruolo del continente in termini geografici, politici ed economici. La c.d. “diplomazia delle mascherine” cosi come gli stessi interventi in campo sanitario a favore di diversi paesi africani contro la pandemia di COVID-19 rientrano, al di là del concreto sostegno umanitario e sanitario che de facto si traduce nell’invio di materiale emergenziale, in una logica di consolidamento di quella politica silente iniziata già durante il governo di Mao allorquando furono instaurate per l’appunto le relazioni sino-africane.
La cooperazione tra i due paesi in quegli anni non fu però soltanto di natura diplomatica. Il sostegno, infatti, ai movimenti di liberazione impegnati nella lotta anti – coloniale si intersecò con un interesse di tipo economico tradotto nei primi sostanziali investimenti e concretizzatosi in importanti progetti infrastrutturali come ad esempio la Tazara, la ferrovia che connette Tanzania e Zambia inaugurata nel 1975. A supporto della tesi non è verosimile pensare che il sostegno alle indipendenze negli anni ‘60 sia traducibile nella pretesa da parte dell’ex impero Celeste di esportare modelli di democrazia universale, visto e considerato che quest’ultima trova difficile identificazione e realizzazione nello stesso modello cinese. La silente ma intensa penetrazione del paese asiatico nei comparti economici, finanziari e infrastrutturali di alcuni stati africani (cresciuta ancora più rapidamente a partire dagli anni 2000 come naturale conseguenza dell’espansione della politica del “GO OUT” del Governo cinese, ossia l’ insieme delle misure adottate a partire dalla fine degli anni ’90 volte a incentivare gli investimenti cinesi all’estero) manifesta l’esigenza di esercitare un vero e proprio colonialismo di mercato cruciale per il proprio sviluppo e per la sempre più crescente sfida globale.

Si potrebbe affermare dunque che attraverso lo strumento della sopra citata cooperazione in campo economico nelle vesti della c.d. “diplomazia del dollaro”, il governo cinese guardi ad un controllo radicale dei paesi che aiuta generando non solo enormi affari ma una rete di influenza strategico – politica su vasta scala. Le dinamiche sopra esposte, la natura ingente degli investimenti cosi come i prestiti facilitati con linee di credito a tasso zero e i lunghi periodi concessi nel ripagare questi capitali rendono questi ultimi sempre più appetibili ma traghettano allo stesso tempo il gigante asiatico all’acquisizione del debito verso i soggetti cui eroga finanziamenti, i quali non avendo a disposizione un surplus finanziario o attivo proprio per ripagare i capitali investiti si indebitano sino al punto di non ritorno.
Quanto analizzato rappresenta lo scenario e il presupposto ideale per potenziare la c.d. Via della Seta nell’ottica dell’ambizioso progetto One Belt,One Road, che trova nell’obbiettivo di rafforzare le relazioni con i Paesi dell’Africa Orientale, la risoluzione al nodo cruciale della c.d. Sea Road (via marittima). La crescente influenza del Dragone cinese impone a rigor di logica la necessità di un intervento da parte dei principali attori mondiali e con essa sorge spontanea l’esigenza di rivedere le strategie sinora adottate. Da un’Europa sempre più frammentata a causa del rafforzarsi dei vari nazionalismi, lontana dall’agire comune dei suoi protagonisti, focalizzati su questioni di politica interna agli States, oggi più che mai, alle prese con le delicate questioni razziali e alla ricerca di un identità politica, bisogna rendersi conto dell’importanza di ristabilire delle linee di equilibrio volte a bilanciare il quadro geopolitico internazionale, la cui simmetria risulta essere compromessa da quella che possiamo definire come una delle più imponenti operazioni politico – economiche del nostro secolo: la colonizzazione cinese dell’Africa.