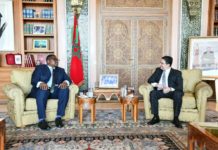di Enrico Oliari, con la collaborazione di Saber Yakoubi e di Giacomo Dolzani
 Esiste un luogo nel deserto della Tunisia orientale, a ridosso della frontiera libica, dove 3.600 disperati vivono da oltre dieci mesi nelle tende, circondati dalla sabbia e da un vento forte e persistente che, oltre ai buoni propositi della Comunità internazionale, a poco a poco spazza via anche la speranza: è Shousha, la casa dei profughi scappati dalla Libia del caos.
Esiste un luogo nel deserto della Tunisia orientale, a ridosso della frontiera libica, dove 3.600 disperati vivono da oltre dieci mesi nelle tende, circondati dalla sabbia e da un vento forte e persistente che, oltre ai buoni propositi della Comunità internazionale, a poco a poco spazza via anche la speranza: è Shousha, la casa dei profughi scappati dalla Libia del caos.
“Quella che doveva essere una sistemazione provvisoria e di emergenza si è trasformata in un accampamento stabile, dove chi vi abita spera ad ogni mattina di ricevere un segnale che sblocchi la propria richiesta di asilo o di trasferimento”, spiega il responsabile militare del campo, un colonnello tunisino sulla cinquantina, disponibile e dalle buone maniere. “E adesso non è niente, doveva vedere quando ci siamo trovati a dover far fronte ad una valanga umana di mezzo milione di persone, in fuga dalla guerra civile d’oltreconfine: solo in questo campo c’erano 50.000 profughi, una dura prova per il nostro paese, fragile e appena uscito dalla rivoluzione”.
L’immensa distesa di tende, molte dell’Unhcr, altre fatte di coperte dai colori sbiaditi, si appiattisce all’orizzonte della pianura desertica: una città nel nulla, lontana da ogni dove e dalle coscienze di tutti. Un’emergenza attualissima, tuttavia dimenticata, rimossa, al punto a gennaio un drappello di deputati dalla pochette verde scatenava l’ennesima bagarre in aula, sostenendo che in Libia è tutto tranquillo, che l’emergenza profughi è finita e che i negher vanno, quindi, rispediti a casa, via dal bianco suolo padano.
Shousha è nata nel febbraio dello scorso anno, quando in molti sono scappati dalle violenze e dai disordini dell’ennesimo paese interessato dalle rivolte della ‘Primavera araba’ e si sono spinte a ovest, verso l’ignoto.
Dopo i primi momenti di caos, dove nel deserto già rovente mancava di tutto, persino l’acqua, ad occuparsi dei profughi è stata la Comunità internazionale, la quale è riuscita gradualmente a prendere il controllo del dramma e a sistemare la moltitudine di profughi nel deserto, dove non ci sono problemi di spazio.
Da allora molti sono partiti: chi ha fatto ritorno al proprio paese, chi è andato a vivere da parenti o da amici, chi ha attraversato il braccio di mare che separa la Tunisia dall’Italia su quelle che noi chiamiamo ‘carrette’, ma che a Shousha si chiamano ‘barche della morte’. Altri sono rimasti al campo, bloccati lì dai più disparati motivi.
“Spesso si tratta di persone provenienti da regioni interessate dalla guerra, come il Darfur o la Somalia, oppure da paesi che li perseguiterebbero, come l’Eritrea o il Ciad”, riprende il comandante militare del campo. “Vi è persino chi è bloccato per via dei complicatissimi problemi burocratici, come nel caso dei palestinesi”.
Impossibile andare verso est: la Libia non li rivuole, nonostante abbiano da sempre lavorato e svolto quegli incarichi che il libico, ultra-assistito dal governo di Gheddafi, non faceva; a sud c’è il deserto e dopo quello l’Africa dei conflitti interminabili; a nord c’è il mare, a ovest la Tunisia, la quale ancora sta metabolizzando gli effetti della sua rivoluzione.
Far convivere gruppi etnici diversi, ciascuno costituito da donne e uomini in forte difficoltà, è stata ed è tutt’ora un’impresa nell’impresa, tanto che nel maggio dell’anno scorso era scoppiata la rivolta, centinaia di tende erano state saccheggiate e distrutte, c’erano state violenze e qualche stupro, era scappato il morto. Oggi, come spiega il colonnello dalle buone maniere, “le cose vanno meglio, abbiamo raggiunto un certo equilibrio, ma non nego che in passato ci siano state tensioni con esiti anche drammatici. Sì, la situazione si è tranquillizzata. Ci sono stati anche una ventina di matrimoni, qui nel campo, due divorzi e diverse nascite”.
La calma e la pazienza di Shousha sembrano riflettere la consapevolezza dell’evidente calo di attenzione nell’opinione pubblica internazionale ed è sufficiente il passaggio di un paio di giornalisti per far vibrare fra le tende la scossa della novità. Ognuno vorrebbe raccontare la sua storia, dire il suo parere, far giungere il più lontano possibile la propria voce e con essa la richiesta, rivolta al mondo intero, di non essere dimenticati, abbandonati alle sabbie del deserto.
Una soluzione? Smembrare le famiglie…
 “Venite, venite nella mia tenda: vi voglio raccontare di come volevano dividere me da mia moglie e da mia figlia”. A fermarci è un giovanotto ben piantato, un ingegnere di una trentina d’anni. Ha una bimba di tre mesi, un fagottino dagli occhi vivi che la fa sembrare una di quelle graziose bambole che un tempo adornavano il lettone della nonna. “E’ una delle ultime nate del campo”, racconta, mentre la mamma della piccola è indaffarata a fare spazio per i nuovi arrivati.
“Venite, venite nella mia tenda: vi voglio raccontare di come volevano dividere me da mia moglie e da mia figlia”. A fermarci è un giovanotto ben piantato, un ingegnere di una trentina d’anni. Ha una bimba di tre mesi, un fagottino dagli occhi vivi che la fa sembrare una di quelle graziose bambole che un tempo adornavano il lettone della nonna. “E’ una delle ultime nate del campo”, racconta, mentre la mamma della piccola è indaffarata a fare spazio per i nuovi arrivati.
“Io mi trovavo in Egitto per turismo, ma sono di Gaza: al Cairo ho conosciuto un tale, un libico, che mi aveva invitato a seguirlo con la prospettiva di un lavoro. Scaduti i 10 giorni di permesso, non sono potuto rientrare in Egitto per poi tornare nella mia città: l’aeroporto di Gaza è chiuso per via dell’embargo di Israele e quindi non mi è restato altro da fare che adattarmi alla mia nuova patria”.
Si chiama Moussa Yusef e si racconta in modo pacato, con voce morbida, quasi incredulo per la situazione in cui si è trovato. “In Libia ho conosciuto Mayssa, mia moglie, che è medico dentista e come me palestinese. O meglio, una ‘palestinese del 48’, di Haifa, la cui famiglia cioè è dovuta emigrare in Libano per via dell’espansione di Israele sul finire degli anni Quaranta”.
Ma non è meglio tornare a Gaza, piuttosto che vivere in un campo profughi?
“Non è così semplice. Una norma proibisce agli abitanti di Gaza di contrarre matrimonio nei paesi arabi e quindi di rientrare a Gaza e comunque mia moglie non potrebbe accompagnarmi. A questo si aggiunge il fatto che Rimas, nostra figlia, è nata qui, in territorio tunisino: l’ambasciatore dell’Autorità nazionale palestinese ha prospettato come unica soluzione possibile al nostro caso lo smembramento della famiglia: io sarei potuto rientrare a Gaza, mia moglie sarebbe dovuta andare a vivere in Libano, mentre nostra figlia non avrebbe potuto lasciare la Tunisia”.
Quindi, per rimanere uniti, avete deciso di rimanere nel campo. In attesa di cosa?
“Da poco l’Unhcr (l’Agenzia delle Nazioni unite che si occupa dei rifugiati, ndr.) ci ha procurato lo status di rifugiati politici, confidiamo che presto un paese europeo ci possa ospitare”.
Due tipi di razzismo: uno di pelle ed uno di opinione.
 La gente del campo ha cercato di rendere vivibile la quotidianità organizzando alcune tende in servizi pubblici: oltre alle due cucine che sfornano rispettivamente 2000 e 1600 pasti, vi è una biblioteca, una scuola di inglese alla quale si accede portandosi un piccolo secchio da utilizzare a mo’ di sgabello, un centro per la preghiera e un bar, al quale troviamo seduto Ahmad: “Sono qui dal primo aprile dell’anno scorso, sono scappato dalla Libia benché io sia nato a Tripoli, da famiglia sudanese. Allo scoppiare degli scontri la mia zona, che si trova nei pressi di una raffineria, è stata tagliata in due e quindi io sono improvvisamente stato separato dalla mia famiglia”.
La gente del campo ha cercato di rendere vivibile la quotidianità organizzando alcune tende in servizi pubblici: oltre alle due cucine che sfornano rispettivamente 2000 e 1600 pasti, vi è una biblioteca, una scuola di inglese alla quale si accede portandosi un piccolo secchio da utilizzare a mo’ di sgabello, un centro per la preghiera e un bar, al quale troviamo seduto Ahmad: “Sono qui dal primo aprile dell’anno scorso, sono scappato dalla Libia benché io sia nato a Tripoli, da famiglia sudanese. Allo scoppiare degli scontri la mia zona, che si trova nei pressi di una raffineria, è stata tagliata in due e quindi io sono improvvisamente stato separato dalla mia famiglia”.
Ahmad ha 26 anni ed è di pelle nera, caratteristica sufficiente per essere accusati di collaborazionismo da entrambe le fazioni nella Libia della rivoluzione.
“Agli immigrati in Libia, se pur di seconda generazione come nel mio caso, non è data la cittadinanza”, racconta. “Essere stranieri e di pelle nera comportava e comporta tutt’ora il sospetto di essere lealisti del vecchio regime, poiché era risaputa l’attenzione del Raìs per l’Africa e per gli africani, una protezione nei confronti degli immigrati che gli garantiva la loro dedizione e la loro stima. Io sono di famiglia sudanese e tanto è bastato ai rivoltosi per identificarmi come un possibile mercenario al soldo di Gheddafi”.
Non le è mai stato proposto di arruolarsi?
“Certamente. Per entrare a far parte delle truppe filo-governative, mi è stata promessa la cittadinanza libica, del denaro e la possibilità di terminare gli studi. Tuttavia ho rifiutato e sono scappato verso la Tunisia. Lungo la strada ho incontrato diversi posti di blocco dei rivoltosi: mi hanno lasciato passare, ma mi hanno sequestrato tutto, compreso il cellulare e la macchina fotografica”.
Una volta oltrepassata la frontiera c’era subito il campo: com’era la situazione allora?
“Qui c’erano 50.000 persone in una situazione umanitaria gravissima: mancavano il cibo, l’acqua, i medicinali, i vestiti… le tende erano insufficienti, i bagni chimici inadatti. Il campo non era come lo si vede oggi, diviso in settori a seconda delle etnie. Anzi, in realtà i campi erano addirittura tre, vicini, gestiti rispettivamente dall’Onu, dalla Croce Rossa e dagli Emirati arabi”.
Immagino vi siano state tensioni, momenti di stress…
“C’è stata anche una rivolta, il 25 maggio, con una marcia di protesta verso la cittadina di Ben Guardane. L’esercito, comprensibilmente, si era messo a scudo della città e dei suoi 58.000 abitanti, vi sono stati disordini… alcune auto con targa libica sono state date alle fiamme, ci sono stati cinque morti”.
Quali problemi incontra oggi nel campo?
“Qui siamo tutti profughi, abbiamo bisogno di una consulenza legale continua. Di tanto in tanto arriva un avvocato, del tutto insufficiente per seguire con la dovuta perizia il caso di ognuno. Non ci resta che aspettare e sperare nell’interessamento della Comunità internazionale. O la fine dell’inverno, quando le acque del Mediterraneo torneranno ad essere calme”.
Sarebbe disposto a tornare in Libia se venisse realizzata la riconciliazione nazionale?
“Quelli con la pelle nera sono visti malissimo in Libia, poiché o sono sospettati di aver militato come mercenari, o perché del sud, appartenenti cioè a tribù sostenitrici del governo del Raìs. In Libia, per dirla in breve, vi sono due tipi di un razzismo destinato a durare: uno di pelle ed uno di opinione”.
Andare in Svezia. Alla svelta.
 “Non è importante il mio nome, ma la mia storia: fa capire come troppo spesso ci si dimentica che siamo tutti esseri umani”. A parlare è un ventenne somalo, chiuso nel suo berretto di lana spessa che lo protegge dalla sabbia portata dal vento.
“Non è importante il mio nome, ma la mia storia: fa capire come troppo spesso ci si dimentica che siamo tutti esseri umani”. A parlare è un ventenne somalo, chiuso nel suo berretto di lana spessa che lo protegge dalla sabbia portata dal vento.
“Abitavo a Mogadiscio con la mia famiglia, nei pressi dell’aeroporto. Una notte sono caduti dei missili ed io e i miei fratelli siamo stati colpiti dalle schegge. Avevo una gamba maciullata, ma all’ospedale mi hanno detto di non avere le cure necessarie; mia madre quindi mi ha portato in Kenya, a Nairobi, per essere operato ma, mentre ero anestetizzato, mi hanno espiantato un rene per rivenderlo, ovviamente senza il mio consenso e senza che io guadagnassi nulla. Una volta dimesso, mia madre mi ha fatto avere i soldi per partire per la Libia, in quanto a Mogadiscio si sparava e così mi sono ritrovato a fare il lavavetri nella terra di Gheddafi. Nel marzo dell’anno scorso, rientrando a casa ho trovato i manifestanti e, allontanandomi, nella confusione sono stato preso dalla polizia. Mi hanno scambiato per un ribelle, sono stato pestato per tre ore e torturato con i cavi elettrici alla testa”.
Tanta brutalità solo per la presunta partecipazione ad una protesta?
“Volevano soldi, 1500 euro… io urlavo che ero un essere umano come loro, un musulmano come loro… ma loro insistevano: botte e scosse elettriche per tre ore, fino a che sono entrato in coma. Dopo 22 giorni mi sono svegliato in un ospedale di Tripoli ed un medico del mio paese mi ha spiegato l’accaduto. Mi ha suggerito di scappare verso occidente, di farmi inviare del denaro da qualcuno. Io non sapevo neppure cosa fosse la Tunisia, ma ho contattato un mio cugino che vive negli Usa, il quale mi ha mandato una certa somma che mi ha permesso di arrivare fino a qui”.
La sua è una storia tremenda, di quelle che lasciano il segno: riuscirà mai a rimuovere quei momenti terribili che ha passato? “Solo coronando il mio sogno: andare in Svezia. Alla svelta”.
Casi disperati, di uomini e donne che si sono trovate vittime degli eventi, persone comuni coinvolte in una guerra che non era la loro. Disperati, che non chiedono altro che di tornare a vivere. Tutti vorrebbero parlare, raccontare del proprio caso ‘speciale’: un sudanese, che ha lavorato in Libia per 22 anni e che non raggiunge la moglie e le figlie in Spagna per non perdere il frutto del proprio lavoro: denuncia di essere stato abbandonato, insieme ai suoi colleghi, dalla ditta petrolifera canadese presso la quale era impegnato, mentre i ‘colletti bianchi’ scappavano in aereo; un uomo del Ciad, disertore da un conflitto ingiustio, che non può rientrare in Libia per via dei nuovi accordi fra i due governi, i quali prevedono la restituzione degli ex militari per processarli; un trentenne somalo operato di polipi alla vescica, costretto con il catetere nella tenda su una brandina senza che nessuno sia passato a medicarlo negli ultimi 20 giorni.
“C’è comunque molta solidarietà fra i profughi, molti hanno un’alta formazione e si prodigano per aiutare i più deboli”, racconta un volontario danese della ong ‘DRC’ (Conseil Danois pour les Refugies, ndr). “Purtroppo sono stanchi, frastornati, costretti in tende che d’estate si trasformano in forni, con il timore di un domani senza futuro, che non si sa dove o cosa porti”. La comunità internazionale è comunque presente… “Diverse ong sono andate via, ma l’Unhcr rimane e non partirà prima che il problema sia stato risolto in modo definitivo”. Una soluzione ancora lontana, a quanto sembra, per il campo di Shousha, dove la prima necessità consiste nel non lasciar tramontare su di esso il sole dell’attenzione internazionale e con esso l’unica speranza per i 3.600 abitanti della città degli ‘uomini dimenticati’.